Arturo voleva fare lo scrittore. Anzi, voleva essere uno scrittore. No, neanche questo era esatto. Voleva che gli altri lo riconoscessero come scrittore. Né l’arte né l’artista sono tali, senza qualcuno che li riconosca.
Nessuno però lo riconosceva, e il motivo sembrava essere sempre lo stesso: i suoi lavori mancavano di profondità, di mordente. Quando doveva mettere in scena dei drammi umani, che intimamente lui sapeva essere il succo e il nucleo di ogni vera letteratura, non riusciva a renderli né forti né credibili. Spargeva sulla pagina problemucci all’acqua di rose, incomprensioni buone per una storiella infantile, niente che potesse scuotere l’anima dei personaggi e, di conseguenza, di chi ne leggeva.
Dopo aver molto riflettuto, Arturo aveva compreso che il suo problema era uno solo: in vita sua non aveva sofferto abbastanza, e per questo era giunto alla conclusione che doveva uccidere qualcuno.
Se si guardava alle spalle, era dolorosamente conscio del fatto che gli era sempre andata troppo bene. Aveva avuto un’infanzia tranquilla, non abbastanza povera da patire la fame e attirare sguardi pietosi, ma nemmeno così ricca da ingannarlo per poi presentargli un qualche tipo di conto con la realtà una volta cresciuto. I suoi genitori, facendo sfoggio di inconsapevole inutilità, erano persone buone, oneste e tutto sommato felici, che litigavano poco, si volevano bene, non nascondevano segreti inconfessabili e l’avevano circondato di un affetto presente ma non asfissiante. Gli avevano insegnato cosa fosse giusto mangiare, ma non gli avevano impedito di godere di qualche merendina. Gli avevano messo a disposizione la possibilità di studiare, di essere creativo, di fare sport, ma non l’avevano mai obbligato, lasciando che lui seguisse le sue inclinazioni ed evitando di proiettare su di lui i loro rimpianti, perché semplicemente non ne avevano. Erano in salute, serenamente pensionati dopo una vita di lavoro, e avevano risparmiato abbastanza denaro per godere di una vecchiaia pacifica fatta di viaggi e relax, lasciando comunque da parte quello che serviva affinché Arturo, privo di fratelli o sorelle problematici, potesse avere la certezza di non finire mai sotto un ponte, anche se le cose gli fossero andate male.
Ma ad Arturo, purtroppo, le cose non erano mai andate male.
Se dalla sua famiglia non aveva ereditato traumi, nemmeno l’adolescenza era stata d’aiuto. Arturo era stato un ragazzo normale, complessivamente sano, di aspetto tutto sommato ordinario. Gli riusciva naturale essere simpatico. Era uno studente dotato e diligente e piaceva a insegnanti e professori. Non eccelleva nello sport, ma non gli interessava più di tanto, e comunque non era così scarso da suscitare occhiate ironiche o risolini soffocati. Con le ragazze non ci sapeva granché, ma quelle poche da cui aveva ricevuto apprezzamento erano state sufficienti a eliminare la possibilità di un proficuo sentimento di inferiorità e inadeguatezza.
Sfortunatamente, non c’era stato modo di essere oggetto di bullismo, da cui avrebbe potuto ricevere le sempre utilissime cicatrici fisiche ed emotive: un po’ per colpa della suddetta simpatia, e un po’ per via del fatto che Arturo era bianco, eterosessuale, non troppo basso, non troppo grasso, non troppo gracile, e non apparteneva ad alcuna particolare minoranza religiosa. Come se non bastasse, nel posto dove era cresciuto mancava quel degrado urbano, sociale, culturale e civile che aveva fatto la fortuna di molti scrittori e scrittrici.
Certo, qualche trauma sarebbe anche potuto venire dall’adolescenza in sé, in quanto groviglio ormonale di sensazioni, umori e calori incontrollabili, ma anche in questo caso Arturo era rimasto deluso. Fin dalla più tenera età si era appassionato alle storie, ai film, ai romanzi, alle serie tv, e aver trovato lì dentro le mille sfumature dei drammi adolescenziali l’aveva messo in guardia rispetto alla potenziale, futura evoluzione dei suoi sentimenti. La conseguenza, forse inevitabile, era stata che Arturo si era ritrovato in mezzo a ragazzini e adolescenti che di storie non ne conoscevano nemmeno una, ma che proprio per questo vivevano le loro come se fossero genuinamente originali e dolorosamente incomprensibili a chiunque altro. Arturo però riconosceva nei loro comportamenti schemi e racconti che già aveva incontrato e in cui non poteva evitare di vedere una ripetizione che ne diluiva di molto il peso.
Superare l’adolescenza, entrare nella vita adulta e poi nel mondo del lavoro, non era servito a molto.
Arturo aveva superato brillantemente l’università, stringendo amicizie sane e normali, e quasi subito aveva trovato un buon lavoro che gli piaceva, per il quale era portato, e che gli aveva consentito di iniziare una carriera che avrebbe anche potuto essere fonte di stress, litigi, tradimenti, sotterfugi, ma che invece era stata semplicemente il percorso di una persona capace che era arrivata ad avere uno stipendio confortante senza sentire su di sé né l’invidia dei colleghi, né l’ansia da prestazione dei superiori.
Si era comprato una casa, e l’aveva riempita di tutte le cose che più gli piacevano al mondo, senza che nessuno avesse niente da ridire.
Perfino le relazioni che aveva avuto erano finite troppo bene. Niente lancio di piatti, niente urla a svegliare i vicini, niente scene madri con facce stravolte e vene sul collo. Arturo era sempre rimasto “in buoni rapporti”.
Non c’è niente di peggio, per un aspirante scrittore, che lasciarsi in buoni rapporti.
Guardandosi allo specchio, Arturo riconosceva a malincuore di essere una persona felice. Facendo un calcolo a spanne, ma probabilmente veritiero, il 99% abbondante della popolazione mondiale aveva o aveva avuto più problemi di Arturo, la cui vita stava scorrendo su un binario che quel 99% avrebbe dato un braccio per poter percorrere.
E Arturo ne era consapevole. Se così non fosse stato, avrebbe potuto provare quella sorta di depressione tipica di certi fortunati che, non riconoscendo il proprio privilegio, si lamentano di qualche immaginaria limitazione della loro identità, traendone la forza per piangerne in modo creativo.
Ma per Arturo non era così, sapeva di non potersi lamentare e non ne aveva nemmeno voglia, non ne sentiva il bisogno.
L’unico problema che ancora persisteva era il desiderio di scrivere.
Certo, non tutta la letteratura, e nemmeno la maggior parte, è fatta di drammi familiari o sociali. Esistono i gialli, i fantasy, la commedia. Ma Arturo sapeva che la vera letteratura, capace di restare nei secoli, era quella che riusciva a raccontare l’oscurità dell’animo umano, magari calandola in qualche genere specifico, ma dando sempre l’impressione di conoscere e poter raccontare l’Abisso.
Gli esseri umani sono naturalmente affascinati dall’Abisso. Forse perché si sentono più vicini ad esso che a certi ideali di perfezione a cui dicono di ispirarsi. Percepiscono che in un punto imprecisato di quel buio c’è una qualche intrinseca verità. O forse perché stare vicini all’Abisso, ma non ancora dentro di esso, gli dà la sensazione di possedere un valore morale e filosofico, una sorta di stoica capacità di resistenza. O forse perché nell’Abisso, insieme alla colpa e al dolore, esiste anche la perdita di ogni inibizione, l’impulso primitivo verso il trionfo del caos, l’invitante cancellazione del proprio essere sociale e la liberazione dell’istinto verso una soddisfazione immediata di ogni desiderio animale. Una tale aderenza al qui e ora del tempo presente, da arrivare a cancellare uno dei concetti più spaventosi mai concepiti dall’uomo, cioè il futuro.
Solo che Arturo l’Abisso non lo conosceva. Non c’era mai andato nemmeno vicino. Aveva letto e guardato le storie di chi l’aveva visto, o che sosteneva di averlo visto, o che aveva parlato a lungo con qualcuno che l’aveva visto. Ma lui ne era sempre rimasto distante, e quando fingi di conoscere l’Abisso basandoti sul racconto che di esso ne hanno dato persone troppo lontane da te, la gente se ne accorge.
Se vuoi fare lo scrittore, essere moderatamente e complessivamente felici è una condanna senza appello.
Il che dovrebbe essere una discreta fonte di frustrazione, ma purtroppo non sufficiente. La vera letteratura non tratta delle piccole frustrazioni, a meno che ce ne siano moltissime sommate le une alle altre, ma di quelle enormi, esacerbanti, che straziano la mente. Anche spremendo dal suo animo tutta l’irritazione per la sua vita agiata, e tutta l’invidia che era capace di provare per chi invece aveva qualcosa di vero e sanguigno da raccontare, Arturo non riusciva proprio a essere una persona negativa, che trovasse nella pagina bianca l’unico luogo dove sputare l’inchiostro nero che aveva dentro.
Naturalmente, esistevano molti scrittori e scrittrici che raccontavano i più angosciosi drammi umani senza avere alle spalle traumi significativi. Ma Arturo era convinto che mentissero, che quei traumi ci fossero, e che semplicemente venissero taciuti al pubblico o fossero stati dimenticati dalla mente cosciente.
Lui invece non aveva traumi, non provava nemmeno il trauma della normalità, quella sensazione soffocante propria di coloro che si sentivano precipitare nella claustrofobia all’idea di vivere una vita identica a quella di tutti gli altri, vittime di una standardizzazione economica e sociale che castrava qualunque vena creativa o rivoluzionaria. Purtroppo, Arturo non sentiva castrata la propria creatività, non voleva fare alcuna rivoluzione, e aveva perfino un’alta considerazione di se stesso, tale da non fargli mai credere di essere esattamente uguale agli altri. E se anche avesse scoperto, nel profondo del suo animo, di non avere il talento per essere diverso dalla massa, quella consapevolezza sarebbe arrivata troppo tardi, forse addirittura in punto di morte, lasciandolo privo del tempo necessario a trasformarla in arte.
Uccidere qualcuno era la sua ultima possibilità. Aveva bisogno di un trauma, e ne aveva bisogno in fretta, perché prima di trasformare un trauma in letteratura era necessario viverlo ma anche assorbirlo, rielaborarlo, comprenderlo. E più fosse stato grande il trauma, più tempo sarebbe stato necessario per metterlo su carta in modo convincente. Allo stesso tempo, se avesse subito un trauma troppo grande, avrebbe potuto perdere il controllo dei suoi pensieri, smarrendo la capacità di dargli una forma verbale compiuta.
Aveva riflettuto sulla possibilità di infliggersi una ferita fisica. Un’amputazione, magari. Qualcosa di piccolo, senza esagerare, un mignolino, ma che gli permettesse di dare una piccola occhiata all’Abisso. Ma non sapeva dire con certezza quanto sarebbe stato abbastanza, e quanto invece sarebbe stato troppo, e comunque aveva sempre avuto troppa paura del dolore fisico.
Avrebbe potuto diventare un alcolista, o un tossicodipendente. Ma per quanto fosse disposto a correre dei rischi per realizzare il suo sogno, quello era troppo grande. Era certamente vero che molti artisti fra i più idolatrati venivano da quel percorso, da un’arrampicata difficile sulle ripide pareti di un Abisso riempito di liquidi e polveri. Ma a fronte del numero apparentemente alto di scrittori usciti da là sotto con qualcosa da raccontare, aveva il sospetto che ce ne fossero molti, molti di più che non avevano avuto alcuna possibilità di scrivere niente, perché le pareti dell’Abisso, una volta arrivati in fondo, non erano più riusciti a scalarle.
Per questo uccidere qualcuno poteva essere una buona soluzione. Nessuno di conosciuto, naturalmente, o per lo meno nessuno di amato. Arturo non voleva vivere il trauma del dolore di una persona cara, il senso di colpa sarebbe stato troppo intenso.
Uccidere un semi-sconosciuto era invece una buona scelta. Nessuna delle persone a lui care avrebbe sofferto direttamente, lui non avrebbe subito dolore fisico, e non avrebbe devastato la sua mente e il suo corpo con sostanze di cui non sapeva nulla.
Ovviamente, però, non voleva arrecare nemmeno troppo danno. Uccidere è un atto di potere straordinario, perché cambia fattivamente la storia umana. Ammazzare qualcuno significa strappare dal futuro tutte le interazioni che quella persona avrebbe avuto da lì alla fine naturale della sua vita. Tutti gli incontri, le parole pronunciate o scritte, gli amori, i figli, le invenzioni, il male, il bene, le informazioni scambiate e ricevute. Una ragnatela complessa e inestricabile che poteva essere completamente annullata col semplice atto di un omicidio. Potenzialmente, un intero albero genealogico potato alla bell’è meglio, con un’intera porzione di storia umana cancellata nello spazio di pochi istanti.
Così però era troppo. Arturo non voleva esercitare un potere così enorme. Per questo non avrebbe potuto uccidere una persona molto giovane, con tutta la vita davanti, perché le ramificazioni potenziali di quella vita erano troppo vaste per potersi arrogare il diritto di cancellarle completamente. Serviva qualcosa di diverso: una persona sola, possibilmente senza figli, magari già troppo anziana per averne, priva di talenti o capacità signiticativi per il genere umano. Una persona il cui futuro fosse sufficientemente privo di eventi, da consentire lo sviluppo di un trauma utile ma gestibile.
Contrariamente alle sue aspettative, Arturo trovò rapidamente il candidato ideale. Il signor Cardarelli, della scala B.
Il signor Cardarelli era pensionato, e il suo stile di vita non lasciava immaginare che godesse di chissà quale rendita o successi passati. Viveva solo, e bastava parlarci per non più di cinque minuti per capire perché: era scorbutico, sgarbato, profondamente egoista. Detestava i bambini dei suoi vicini di casa, riusciva sempre a trovare qualcosa per cui lamentarsi, dal meteo al calcio alla politica, ed era capace di raddoppiare la durata delle riunioni di condominio questionando senza posa su questioni di nessuna importanza.
Al signor Cardarelli, con ogni probabilità, non restavano più di dieci anni di vita, perché era già molto vecchio. Dieci anni che avrebbe passato sempre nella stessa casa, senza costruire particolari legami con nessuno, e infastidendo il suo prossimo quel tanto che bastava a farlo segretamente compiacere della sua morte, senza per questo lasciare una traccia abbastanza vivida da creare particolari ricordi in qualcun altro. L’unico trauma che avrebbe potuto generare era quello della persona che avrebbe preso la sua vita.
Arturo prese la decisione definitiva pochi giorni dopo l’annuncio della vittoria, in un importante premio letterario, di un romanzo scritto da una persona che evidentemente conosceva un suo particolare Abisso e aveva saputo metterlo sulla pagina. Non c’era tempo da perdere.
Arturo uccise il signor Cardarelli in una bella mattina di maggio, fresca e soleggiata, in una viuzza poco distante dal loro condominio.
Non volendo passare la vita in carcere, e anzi convinto che mentire alle autorità gli avrebbe permesso di aggiungere sfumature interessanti al suo futuro trauma, Arturo si premurò di uccidere il signor Cardarelli investendolo con la macchina mentre attraversava la strada. Aveva infatti letto che l’omicidio stradale, quello causato non consapevolmente, ma a seguito di un mancato rispetto delle norme del codice, poteva portare a una pena fino a sette anni di carcere, e Arturo aveva deciso che sette anni passati in un luogo dove l’unica cosa da fare era riflettere e scrivere fossero un prezzo tutto sommato ragionevole per riuscire a guardare l’Abisso ed estrarre da esso l’arte a cui bramava.
Arturo ebbe cura di tenere in mano il cellulare e fissarlo mentre investiva il signor Cardarelli, anche se era quasi sicuro che in zona non ci fossero telecamere. Nessuno comunque avrebbe potuto dubitare della sua storia, perché Arturo non aveva precedenti penali e non aveva mai litigato col signor Cardarelli, né ci aveva mai parlato al telefono. Si era trattato di un tragico incidente, causato da una colpa evidente, ma non così grave da giustificare sentenze troppo gravose.
C’era però un piccolo dettaglio che Arturo non aveva previsto. Un’unica falla in un piano altrimenti lineare, ben pianificato, logicamente ineccepibile. Non conoscendo nulla dell’Abisso, se non informazioni esclusivamente di seconda o terza mano, non aveva alcuna percezione chiara di quanto potesse essere profondo, o di quanto ingannevole potesse essere il ciglio che si protendeva su di esso.
Mentre guardava il signor Cardarelli, che non era morto sul colpo come aveva sperato, Arturo incrociò lo sguardo con lui. Nei suoi occhi vide qualcosa di cui probabilmente aveva letto in passato, ma di cui non era mai stato testimone diretto. Un miscuglio di paura e stupore, ma soprattutto un infuocato desiderio di vita, semplice, assoluto, totale.
E Arturo scivolò. Perse l’equilibrio proprio sul margine del burrone, e mentre si inginocchiava e si affrettava ad abbracciare e sostenere la testa del signor Cardarelli, stava già cadendo senza più alcun appiglio, con la luce dietro di lui che cominciava ad appassire, mentre l’ombra più in basso montava a una velocità inaspettata.
Quando chiamò l’ambulanza e la polizia, come già aveva pensato di fare, la voce di Arturo tremava, così come le sue mani. Continuò a fissare gli occhi del signor Cardarelli, finché questi, pochi minuti prima dell’arrivo dei soccorsi, smisero di guardare lui e si concentrarono su un qualche punto imprecisato alle sue spalle.
In piedi in mezzo alla strada, circondato dalle urla lente e inudibili di alcuni passanti, Arturo si trovò a pensare che Bene e Male erano sì categorie astratte, soggette a un ampio margine di arbitrio, e capaci di cambiare moltissime facce nel corso della storia. Allo stesso tempo, questa loro malleabilità si applicava solo alla grande massa puntiforme dell’umanità, ma non alla vita e al sentire del singolo individuo, che invece aveva un’idea molto chiara del confine fra quelle due categorie. Un confine personale, certo, ma scavato in profondità.
Di fronte al volto insanguinato del signor Cardarelli, al cospetto del corpo spezzato dalla sua ambizione, Arturo vide il Male, e la profondità dell’Abisso si spalancò davanti a lui con una forza tale da cancellare ogni pensiero e azzerare qualunque volontà.
Quando la polizia lo interrogò su quanto era successo, Arturo raccontò tutta la verità, senza tralasciare nemmeno un particolare. Venne sottoposto a una perizia psichiatrica che lo dichiarò capace di intendere e di volere, e non avrebbe potuto essere altrimenti, visto che Arturo era una persona razionale, metodica, conscia dei propri desideri e perfettamente in grado di ricostruirli. Dopotutto, con le parole ci sapeva fare.
Il processo fu breve e si svolse di fronte a pochissime persone. Il gesto di Arturo poteva essere considerato abbastanza straniante da attirare l’attenzione di qualcuno, ma lo scarso valore della vittima, in termini giornalistici, finì con lo spegnere qualunque possibile riflettore sulla vicenda. Il signor Cardarelli non aveva famiglia né amici, mentre quelli di Arturo non se la sentirono di partecipare. Al processo presenziarono solo i suoi genitori, che gli sorrisero mestamente mentre lui raccontava nuovamente al giudice tutta la vicenda. Mentre parlava, Arturo li guardò, e le loro facce risplendevano lassù, sopra le pareti del pozzo, dove si intravedeva ancora una luce lontana.
Venne condannato a ventidue anni di carcere, che accettò con gratitudine. Ma quello non fu il fondo dell’Abisso, perché in quel momento Arturo stava ancora cadendo. Quando alla fine ci arrivò, al fondo, lo trovò completamente diverso da come se lo era immaginato.
Nei primi cinque anni di galera, Arturo si comportò da detenuto modello. Fece amicizia con altri carcerati, ascoltò le loro storie, assorbì direttamente molte versioni dell’Abisso. Perse tutte le sue amicizie fuori dalla prigione, e rimase in contatto soltanto con i genitori, che a ogni visita gli parvero più vecchi e stanchi della precedente.
Non scrisse nemmeno una riga. Ogni volta che provava a guardare un foglio bianco non c’era spazio per le parole, perché l’intero riquadro era occupato dal viso del signor Cardarelli.
All’inizio del suo sesto anno di prigionia si vide contattare da un uomo che non conosceva. Venne a sapere che una ragazza, una dottoranda di psicologia alla Statale di Milano, aveva scritto una tesi in cui accennava anche a lui, a quella persona normale che a un certo punto aveva deciso di fare qualcosa di assurdo.
L’uomo che era andato a parlare con Arturo era stato mandato da una casa editrice il cui proprietario era anche professore nell’università dove la ragazza aveva presentato la tesi. La casa editrice sapeva perfettamente quanto stampare l’Abisso fosse utile a vendere copie, e voleva che Arturo desse la sua versione della storia.
Dal canto suo, Arturo scoprì che la sua vicenda, e il suo personale Abisso, erano l’unica cosa che il suo cervello gli avrebbe permesso di scrivere, e così fece.
Nel libro parlò soprattutto di rami, di futuri e di passati. Provò a descrivere il Male per come lo vedeva, e provò a capire quale fosse la differenza fra le vite che aveva deciso di cancellare e storpiare – la sua, quella dei suoi genitori, quella del signor Cardarelli – e quelle che dalla sua esistenza e dalla sua testimonianza potevano essere in qualche modo influenzate. Una volta completato, il libro gli sembrò bruttissimo, del tutto inadeguato a descrivere quello che sentiva. Sopra ogni cosa, gli sembrò autoassolutorio, al punto che ne provò vergogna e disgusto.
Quando gliene mandarono una copia, Arturo sapeva che in copertina c’era un anonimo motivo geometrico, ma lui riusciva solo a vederci la complessa trama delle rughe del signor Cardarelli, come da anni accadeva su tutti i fogli che avrebbero dovuto contenere tutte le storie che non aveva mai iniziato.
Quando vinse il Premio Strega e ottenne un permesso per andarlo a ritirare, Arturo salì sul palco e sentì parlare di redenzione, di recupero dei detenuti, di fiori che germogliano sull’asfalto, e altre cose simili. Ricevendo il premio fece dei ringraziamenti generici, parlando a bassa voce, lasciando che la bocca si muovesse automaticamente mentre lui fissava i volti dei suoi genitori. In loro vide un affetto costantemente tenuto a bada dalla precisa certezza che non avrebbero mai voluto vederlo ricevere quel premio, non avrebbero mai voluto vederlo scrivere, non avrebbero mai voluto vederlo diverso da come l’avevano sempre visto fino a quella mattina di maggio.
Negli anni successivi Arturo aspettò con pazienza. Non scrisse nient’altro, e presto la memoria collettiva del suo successo svanì, per ritornare solo in qualche blanda discussione fra appassionati. La sua buona condotta e il suo breve ma intenso successo letterario gli garantirono progressivi sconti di pena, che gli permisero di uscire dopo undici dei ventidue anni previsti.
Era ancora relativamente giovane e, per quelli che ancora si ricordavano di lui, era tuttora uno scrittore.
Tornò a vivere con i suoi genitori, che furono felici di averlo a casa con loro. Trovò lavoro come magazziniere, e attese.
Suo padre morì dieci anni dopo, mentre sua madre attese altri quattro anni.
Cinque giorni dopo il funerale, Arturo era sicuro di avere riflettuto a sufficienza su tutte le implicazioni.
Mentre si suicidava, due decenni dopo l’effettiva realizzazione del suo sogno più grande, ebbe la rassicurante certezza che la sua scomparsa non avrebbe causato troppo disturbo, non avrebbe rovinato alcun piano, non avrebbe spezzato alcun futuro. Probabilmente sarebbe uscito uno striminzito trafiletto sui quotidiani, un riquadro piccolo piccolo che non avrebbe tolto eccessivo spazio a notizie più importanti. Forse qualcuno si sarebbe dispiaciuto, ma anche chi aveva apprezzato il suo romanzo, nel sentire della sua morte, avrebbe pensato che in fondo non era stato un finale così imprevedibile, e non avrebbe avuto difficoltà nell’andare avanti con la stessa vita che avrebbe fatto se Arturo non fosse mai esistito.
Ripensando al Male che aveva scelto di compiere e al Bene che non aveva mai saputo apprezzare, Arturo ebbe cura di non lasciare alcun biglietto o lettera d’addio. Non solo perché non c’era nessuno che avrebbe avuto voglia di leggerla, ma soprattutto perché l’unica cosa che in quel momento gli interessasse, appena prima di affrontare un nuovo Abisso di cui non conosceva nulla, era avere l’assoluta certezza di non essere uno scrittore.

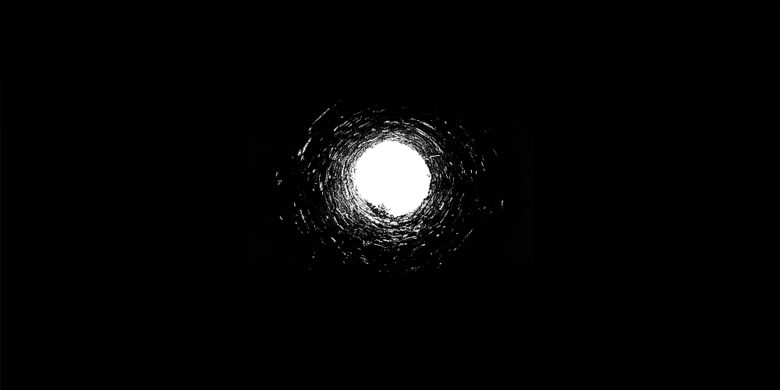



Commenti
bellissimo. La mai banalità del male e del bene
del Post
Grazie!